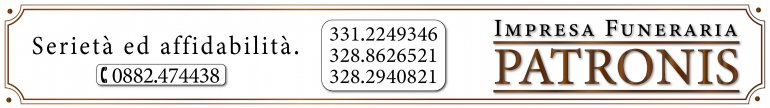Lungi dall’ergermi a cultore assoluto del Carnevale sannicandrese, sul quale, in ogni epoca recente, si sono scritti fiumi di roba, tra presunte ricerche storicamente attendibili, opinioni e valutazioni di ogni sorta, da parte di persone che vi hanno dedicato molto più tempo del mio, mi preme condividere qualche aspetto, nella più sommessa sintesi, tanto per cercare di chiarire un po’ il panorama attuale, alla luce del passato.
Partendo da un’affermazione che, oltre ad essere generalmente condivisa, è obiettivamente e storicamente plausibile, il Carnevale sannicandrese era l’espressione, con singolari elementi di schiettezza e genuinità, di quella salace dissolutezza che trae le sue antichissime e universali origini dalle dionisie e dai culti orgiastici delle civiltà protostoriche.
In altre parole, era il mezzo con il quale, nei limiti imposti dalla condizione sociale della civiltà contadina (ivi incluso il disagio economico, la morigeratezza come “cultura dell’onore”, l’etica cristiana), i sannicandresi riuscivano a manifestare quel sovvertimento dell’ordine sociale da cui il carnevale in sé trae origine. E proprio in questo “sovvertimento”, in una società cementata dalla povertà e dalla miseria, si instaurava la estemporanea esibizione di una improbabile ed agognata ricchezza da parte del ceto medio-basso. Per rendere in modo ancora più efficace quanto detto – e i più anziani converranno con me – il Carnevale sannicandrese (come d’altronde il carnevale in genere) si manifesta anzitutto come una sorta di culto della “gràscia”, di quell’abbondanza dal sapore dionisiaco, all’indomani del “rito” dell’uccisione del maiale.
Nel XVII secolo – e qui si deve rendere merito all’abilità in “caccia archivistica” dell’amico Vincenzo Civitavecchia - a San Nicandro Garganico si parla di Carnevale come una festa dell’esibizione di quella “grascia”. I primi documenti in cui è citato il Carnevale, sono degli atti notarili tra promessi sposi (si, anticamente il matrimonio era un vero e proprio contratto-compromesso), in cui si riferisce spesso che la sposa porta in dote, tra le altre cose, quanto aveva esibito in occasione del Carnevale, per dimostrare di essere all’altezza di quel matrimonio e degna di unirsi ad un uomo con un reddito.
E’ qui che si deve leggere in modo esatto il vestito della pacchiana, che non è il vestito tradizionale del carnevale sannicandrese ma propriamente il vestito classico della tradizione sannicandrese per le occasioni di festa! (relegare un vestito tradizionale a maschera di carnevale, è uno scherno disdicevole alle proprie origini!). A carnevale poi, per i motivi appena elencati, la pacchiana diveniva particolarmente “pacchiana” proprio perché doveva esibire le sue ricchezze, tirando via il meglio che aveva, in stoffe e ori, dal comò, quella sorta di forziere tramandato di madre in figlia in un’aura quasi cultuale, come fosse un ultimo santuario dell’antico matriarcato romano. Con un pizzico di genuina furbizia, gli ori si chiedevano anche in prestito, a parenti e vicini, quasi un contributo mutualistico – anche questo, elemento distintivo e, ahimé, quasi perduto della civiltà contadina - per “far andare a sposare” la figlia di tizio. Di qui, un’osservazione frutto di studi e comparazioni fra tradizione orale, materiale documentale (invero scarsissimo) e fotografico. I galloni d’oro della “gonnella” (la vunnèdda) non erano certo distintivi delle “famiglie ricche”: una volta per tutte sfatiamo questo mito, che ha riempito le strade dei nostri carnevali di pacchiane omologate! Per le famiglie agiate – e a San Nicandro non vi furono stanzialmente mai nobili di sangue ma solo pochissime famiglie ricche dell’aristocrazia terriera – sarebbe stato un “disonore” vestire la pacchiana che era un abito del popolo: nella ritualità della società antica, gli abiti, alla stregua, ad esempio, dei paramenti sacerdotali, erano il primo mezzo di distinzione delle varie “dimensioni” sociali, perché quello più diretto. I galloni d’oro della gonnella, dunque, altro non erano che il naturalissimo pendant allo sfarzo aureo delle donne da marito. Nel confronto tra il variegato materiale fotografico a disposizione, ad esempio, appare chiaro come le donne da marito – salvo alcune eccezioni di circostanza – portassero molti più ori e la gonnella con i galloni dorati, preferendo orecchini a “mazzettino” o a “pera”, più vistosi. Le donne sposate, invece, esibivano pochi ornamenti aurei e con una singolare finezza negli abbinamenti (un laccio di natura ereditaria diretta, gli anelli, orecchini per lo più a borchia (ma, non avendone, si continuava ad usare anche quelli a pendenti), bracciale e una spilla se si avevano. La gonnella, poi, presentava in questo caso i caratteristici “fascioni” in seta, di colore vario su un panno, quello della gonnella appunto, che non era mai nero, ma della gradazione più scura possibile (perciò sembra nera nelle foto d’epoca) del medesimo colore dei fascioni.
Sul patrimonio aureo, ebbi anni fa l’immenso onore di collaborare con l’editore Claudio Grenzi per il volume “Gli ori del Gargano”: mi si aprì un mondo nuovo, nel conoscere le più disparate forme dell’arte orafa popolare e il loro utilizzo mai casuale. Di questo patrimonio, si deve dare atto e merito alla capacità straordinaria di conservazione ad opera di alcune confraternite, in particolare l’Arciconfraternita del Rosario, grazie ai donativi che le donne facevano alla Madonna per chiederne le grazie o in pegno di preghiere esaudite.
Tornando al Carnevale, per ciò che ci è dato sapere fino ad ora, a San Nicandro mai si parlò di maschere, se non dalla prima metà del secolo scorso. Il mascherarsi, infatti, era appannaggio di classi agiate e delle corti dei nobili. A tal proposito, vi è la prova storica ed inedita della storicità del carro carnevalesco anche a San Nicandro, già tra i secoli XVII-XVIII, seppure soltanto presso la corte borbonica: sarà argomento che si approfondirà con la debita conoscenza e a tempo dovuto.
Il fatto di tirare fuori dal comò il meglio della dote, dunque, ha prodotto quasi parallelamente un vero e proprio scherno di questa pratica quasi cerimoniale: dal comò, soprattutto presso il basso ceto, si finì per tirar via di tutto, passando agli armadi, ai bauli, alle cassapanche, immergendosi quasi con isteria ludica in qualsiasi cosa che avesse le sembianze di stoffa, con risultati che rimandavano, solo a vedersi, ai “fescennini” degli antichi popoli italici. Lo scherno, poi, passò presto ad assumere anche forme mimiche e teatrali, realizzandosi nelle macchiette de “lu ditt”. Durante il Carnevale, quindi, San Nicandro divenne un vero e proprio teatro dell’arte di strada, identificata particolarmente dai personaggi che tutti abbiamo conosciuto, almeno per sentito dire: consapevolmente o meno che sia, l’estivo “Festival degli Artisti di Strada” trova, in questo fenomeno, un retaggio storico senza eguali, su cui si dovrebbe investire, unitamente a quelle altre due, tre manifestazioni che già da se creano indotto nell’intero anno solare.
E’ chiaro che, con il diluirsi della civiltà contadina nella modernità, fino quasi a scomparire, il Carnevale sannicandrese storico, quella delle cosiddette genuinità e spontaneità, non ha più motivo di esistere, non fosse altro che per un fatto squisitamente fisiologico.
Per tutto l’anno, la nostra vita è ormai scandita dalle mode, da ciò che le potenze mondiali ci inseminano in mente tramite i media senza che ce ne accorgiamo: del Carnevale sannicandrese è morto lo spirito anzitutto individuale e, quindi, collettivo, che più non nasce nelle nuove leve perché mutati sono i tempi. E poiché il Carnevale è sintomo stesso della società, oltre ad essere storicamente una festa delle più sincretistiche, ben vengano tutte le sue manifestazioni. Siano esse le “scamiciate” della nonna, di contadina memoria. Siano i carri, che un po’ mediano tra il carnevale genuino di piazza e quello ricercato dei costumi artefatti – e si dia merito anche al grande lavoro e agli enormi sacrifici economici, logistici e di tempo dei gruppi, segno che ci sono energie volenterose, in questa città, che si sperano impiegabili anche in altro. E ben vengano, infine, i “criticatissimi” veglioni (salvo poi le sale sempre piene, stracolme), anch’essi una manifestazione sintomatica del carnevale di oggi, la parte in assoluto più lontana da quella civiltà contadina di cui si diceva, giacché rimandano più al carnevale “chiuso” delle nobiltà e delle corti di un tempo, benché non sussista affatto nemmeno lontanamente il concetto di nobiltà o agiatezza.
Non si può, perciò, recriminare nulla ad alcuno, tantomeno a chi il carnevale non lo fa in nessuna delle tre forme, preferendo – per i motivi più vari, anche intimi e personali – il comodo ruolo dello spettatore, nel migliore dei casi.
Epperò, se si tornasse a lavorare sul concetto di Comunità, smettendola di servirsi comodamente di quella forza centrifuga, che ci porta a spedire al più presto i nostri figli via da qui, in una distruttiva disaffezione per le proprie radici senza eguali (e per la quale si richiederebbe un trattato storico e sociale di lunghe pagine), se si tornasse a nutrire un po’ di sano orgoglio per quello – l’amore per la terra natia – che, anticamente come ora, è uno dei più nobili ed ineluttabili sentimenti cavallereschi (quella, si, è nobiltà), si tornerebbe certamente anche a pesare il valore degli spazi comuni, come la piazza. E in essa, tra le altre cose, il Carnevale, quello stesso che era rinomato ovunque, nonostante fatto di “quello che si poteva” e senza aiuti di alcuno, se non di se stessi.
Foto: donne sannicandresi in abito da pacchiana. Posa fotografica in occasione del Carnevale (anni '20 del Novecento). © Claudio Grenzi editore